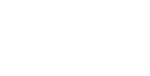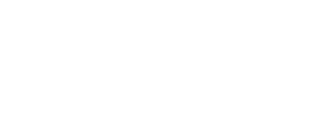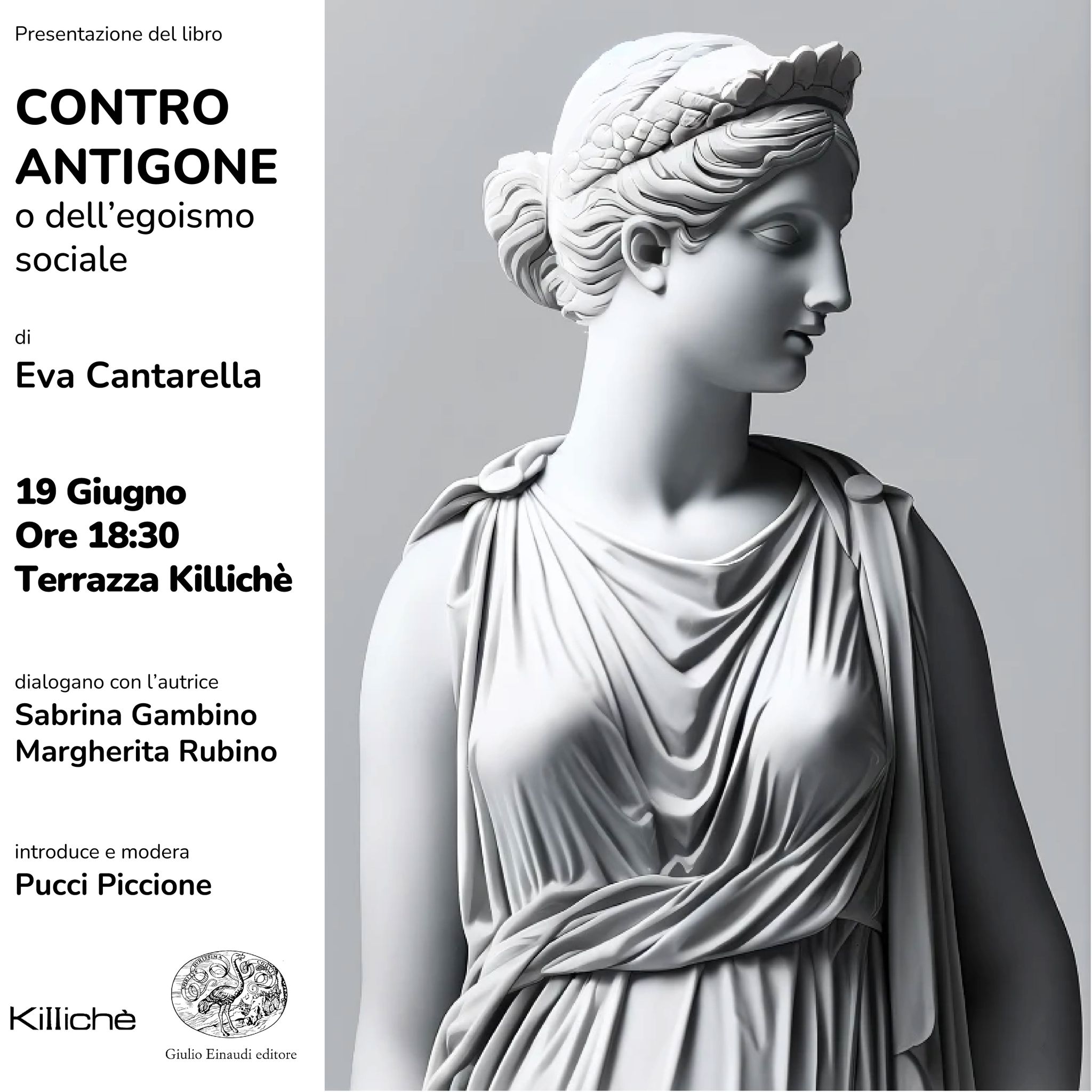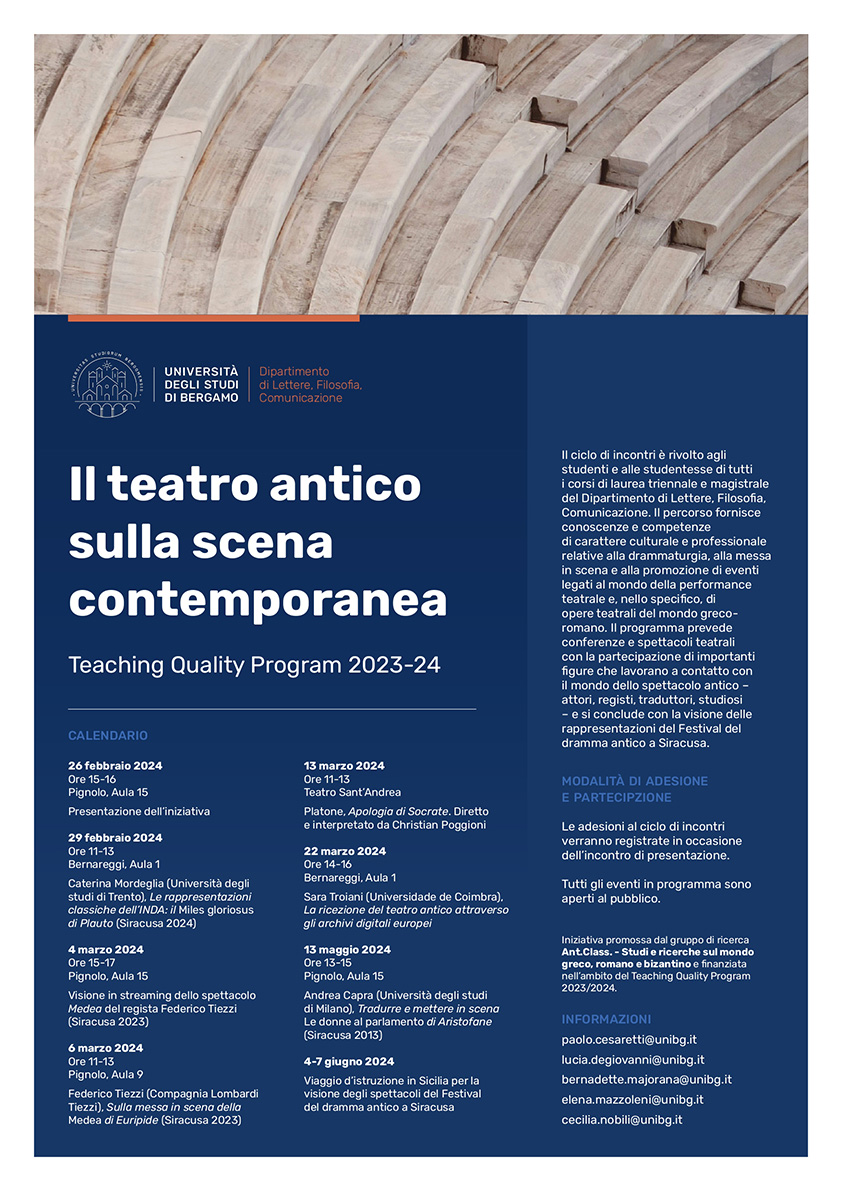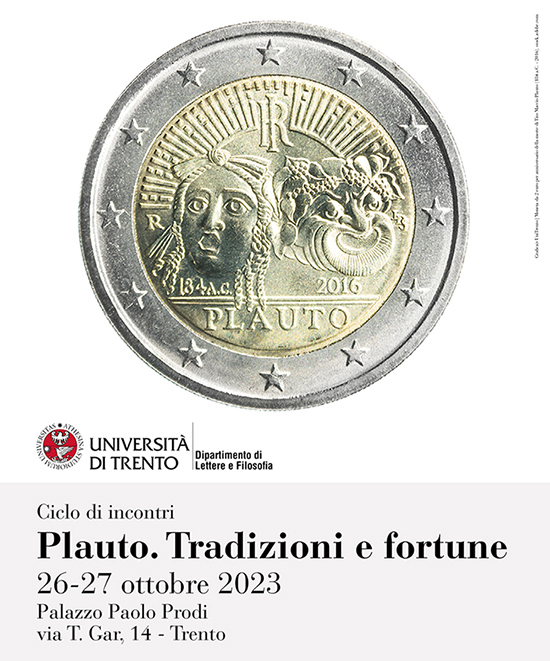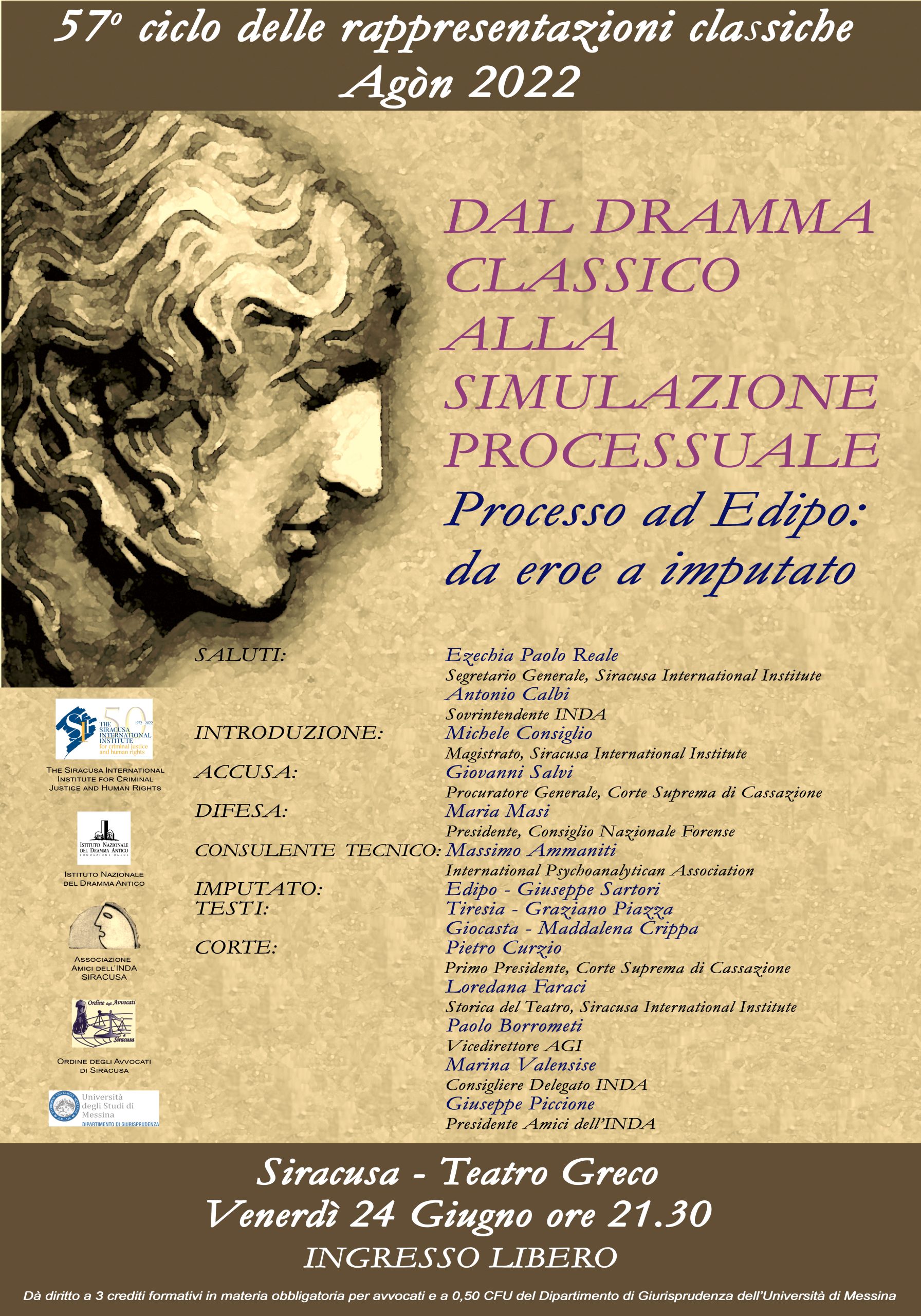La vendetta di Medea. Cratere a volute di Canosa, IV sec a.C. Museo di Monaco
Solo il pubblico sa che ormai Medea porta una maschera e sotto la maschera è tornata ad essere la maga, la strega, l’assassina, la straniera, la barbara. Ma anche la discendente del Sole, la donna di stirpe divina che pone le distanze fra sé e gli “altri” e isola in un cerchio magico e sacrale, se stessa e i figli…
La tragedia che Euripide presenta al pubblico di Atene nel 431 a.C. non è l’unica che porti in scena questo personaggio. Eschilo, e soprattutto Sofocle avevano prodotto molti drammi (ora perduti) sulla saga degli Argonauti, e senza dubbio in alcuni di questi Medea aveva la sua parte. Ma solo con Euripide l’attenzione si focalizza totalmente sulla donna di Giasone.
Già nel 455 Euripide fa rappresentare le “Peliadi” (la macabra messa in scena dell’uccisione di Pelia da parte delle figlie su istigazione di Medea), negli anni intorno al 440 è la volta dell’”Egeo” (Medea ad Atene, sposa di Egeo, e il suo tentativo di avvelenare Teseo). Entrambe le tragedie sono perdute, la trama è ricostruibile attraverso fonti e testimonianze indirette.
Dunque, in successione: Peliadi, Egeo, Medea. E’ evidente che a Euripide interessa l’avventura di Medea in terra ellenica, e quindi la donna-sposa-madre, non la maga-fanciulla ritratta da Apollonio Rodio nel suo paese d’origine. Ma in questo itinerario teatrale egli non osserva la successione temporale dei fatti, per cui parte da Iolco di Tessaglia, approda ad Atene e poi torna indietro per affrontare la Medea di Corinto, il vero nodo di tutta la vicenda. I titoli stessi delle opere sono rivelatori, come se la vera Medea si potesse comprendere ed eventualmente giudicare solo dopo i fatti di Corinto. […]