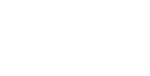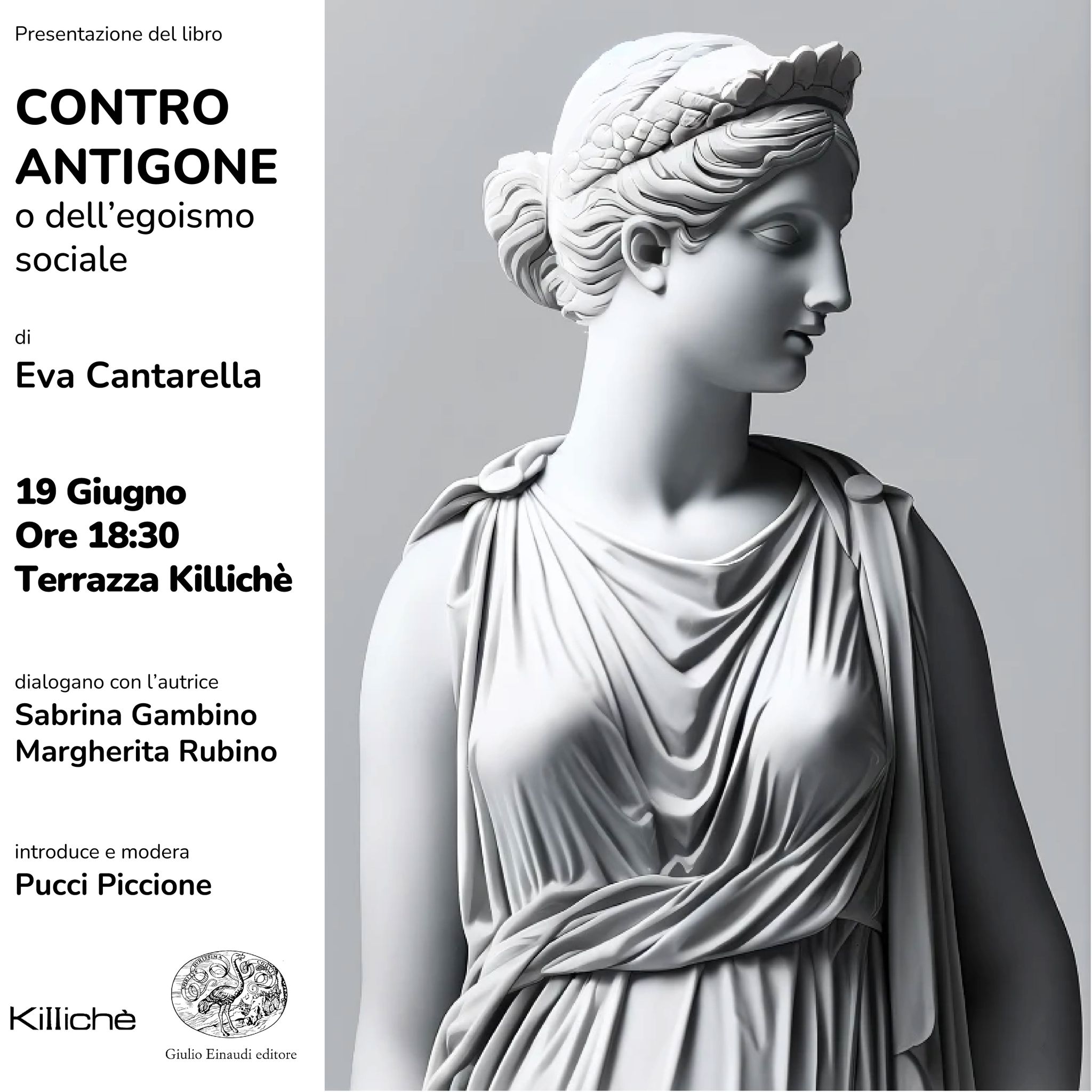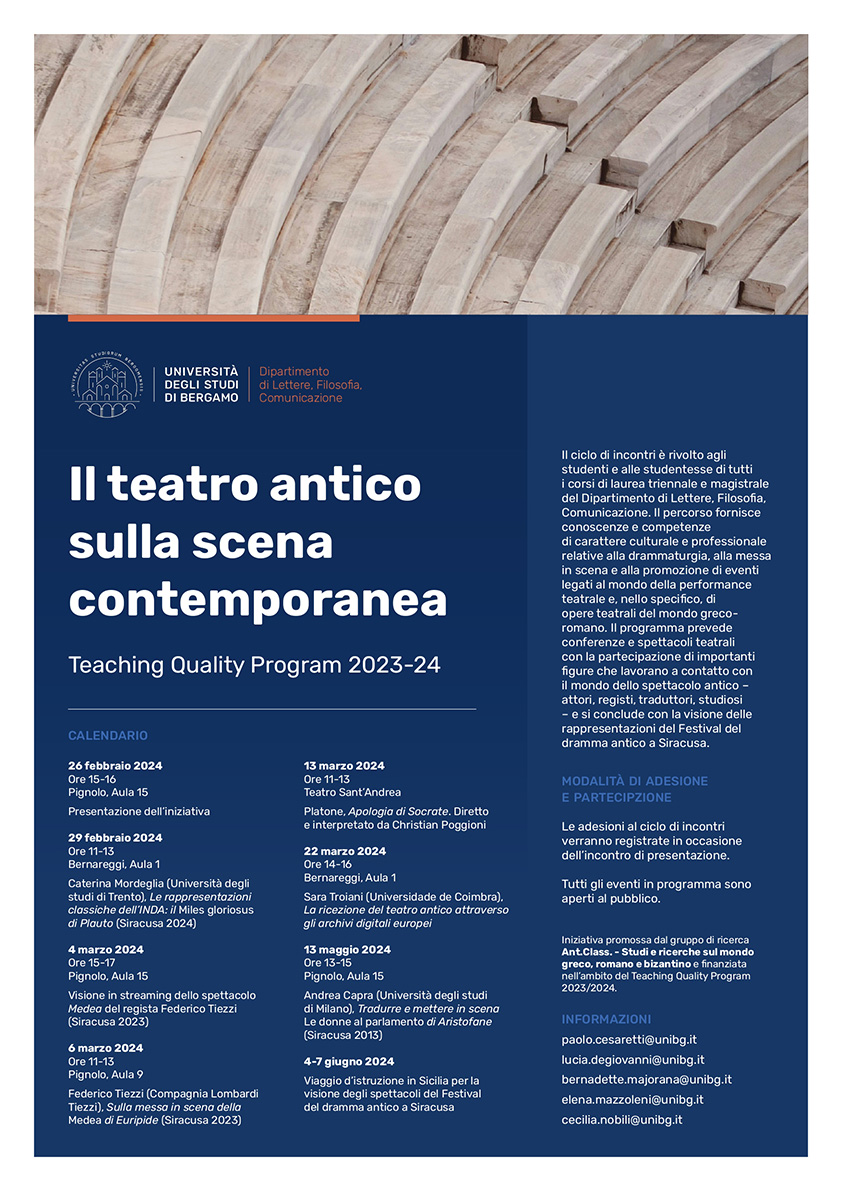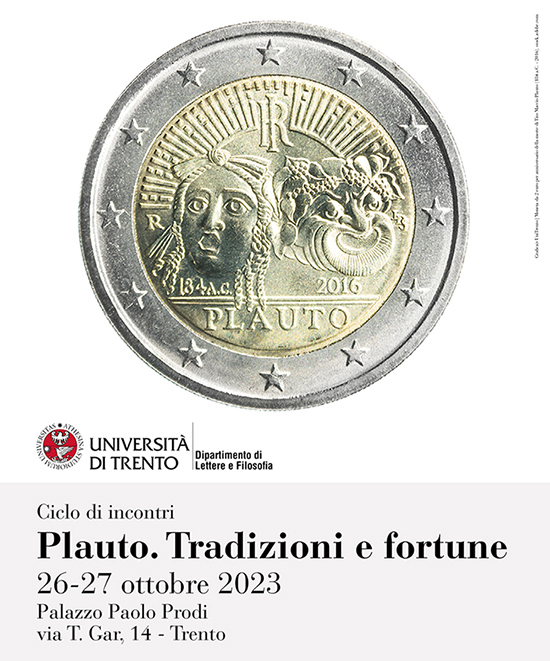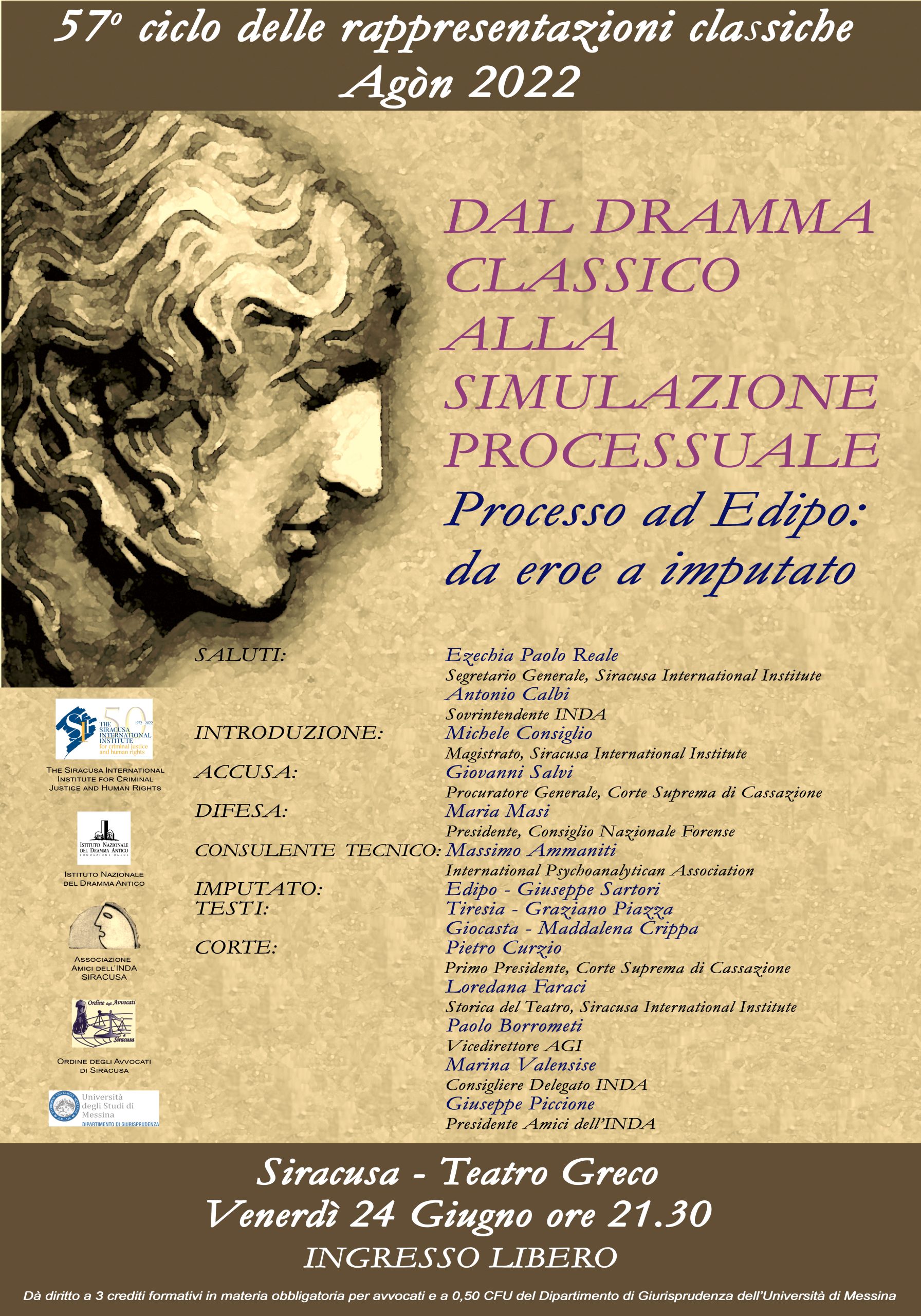L’arcaica vendetta e il più elevato concetto di Giustizia rivivono a Siracusa tre capolavori della tragedia. Tornano a rivestirsi di folla, soprattutto di una folla di giovani studenti, gli alti e immensi spalti del Teatro Greco di Siracusa per gli spettacoli classici dell’INDA, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico. E rivive quest’anno nella sua interezza l’ Orestea di Eschilo. Quell’ Orestea considerata una delle creazioni più alte di tutti i tempi. Dove troviamo i temi della grande Tragedia: l’ineluttabilità delle leggi divine, l’ereditarietà misteriosa del delitto, l’intimo contrasto tra la voce della natura e un ordine superiore, l’adempimento di una legge di giustizia nelle umane vicende. Torna il capolavoro eschileo nella sua interezza a distanza di quasi mezzo secolo, da quando tra i protagonisti figurava un fiero e nobile Vittorio Gassman che firmava anche la regia (ora l’impresa, e riuscita, è toccata a Pietro Carriglio) avvalendosi di una nuova e vitale versione commissionata a Pier Paolo Pasolini. La stessa oggi riproposta. Una versione che non cerca una mediazione classicistica ma si lega al nostro tempo presente. Anche a sottolineare questo, l’anteprima di mercoledì aveva visto, alla fine, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso leggere un passo dello storico George Thomson sulla vittoria della Giustizia sul concetto di vendetta.
È Agamennone che apre la trilogia. Ed è Agamennone colui che rappresenta il primogenito della maledizione abbattutasi sulla stirpe degli Atridi, ma anche la vittima sacrificale. Al suo ritorno dopo la vittoria su Troia troverà ad attenderlo la morte per mano della moglie Clitennestra che ha voluto vendicare il sacrificio della figlia Ifigenia con la complicità di Egisto, futuro despota. Tragedia possente, ma è Le Coefore il momento centrale della trilogia di Oreste che racconta quel nodo di vendetta-giustizia che l’eroe scioglie uccidendo l’usurpartore e la propria madre, rei dell’assassinio. Misteriosa e terribile è la tragedia del labile confine tra responsabilità umana e giustizia divina. E qui a giganteggiare è appunto Oreste, di cui a fare anche la grandezza del personaggio è l’angoscia di esitazione, quell’incrinatura interiore che ritroveremo in Amleto. Una tragedia, Le Coefore , rapida e intensa i cui fulminei accadimenti costituiscono i passaggi di un terribile rituale religioso: il sangue che va lavato col sangue, il delitto che va purificato con un delitto anche più fosco: il matricidio. La catena dei delitti solo alla fine è interrotta dall’intervento divino nelle Eumenidi . E sarà questa la dichiarazione religiosa di Eschilo, l’omaggio al sovrannaturale al quale l’uomo non può sottrarsi.
Impresa difficile, quella di Carriglio, ma affrontata con tenacia, senza sicurezze preconcette. Il regista fa bene ad adeguarsi alla pasoliniana strategia di ‘smascheramento’ di un classico così illustre eppure così antropologicamente ambiguo e fa anche bene a far emergere il senso della legge cui gli uomini devono sottostare. Lavorando bene sui cori, mai forzando le tinte, semmai recando allo spettacolo una forte dose di spettacolarità.
Nei ben meditati costumi, sempre di Carrriglio, che da una bella grecità (tonalità soprattutto brune e nere) trapassano a un accennato modernismo, si erge a recitare una falange di attori valenti, quasi tutti persuasivi. Fisico asciutto, vocalità superba, nel ruolo di Oreste il giovane Luca Lazzareschi si rivela forse il migliore di tutti. Ma bravissima anche Galatea Ranzi, prima a dare algido furore a Clitennestra e poi giusta sofferenza ad Elettra. D’alta scuola l’Agamennone di Giulio Brogi e così l’Athena di Elisabetta Pozzi. Ma non deludono nemmeno Luciano Roman. Maurizio Donadoni, Liliana Paganini, Simonetta Cartia, Giancarlo Condè e, validissimo corifeo, Stefano Santospago. Ben inserite, d’alta civiltà, le musiche di Matteo D’Amico. Quaranta le repliche, fino a giugno inoltrato. A sere alternate, Agamennone e, unificate, Coefore ed Eumenidi.
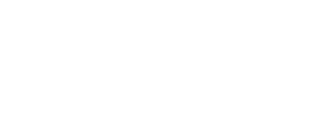
La trilogia di Eschilo per difendere la legalità
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER